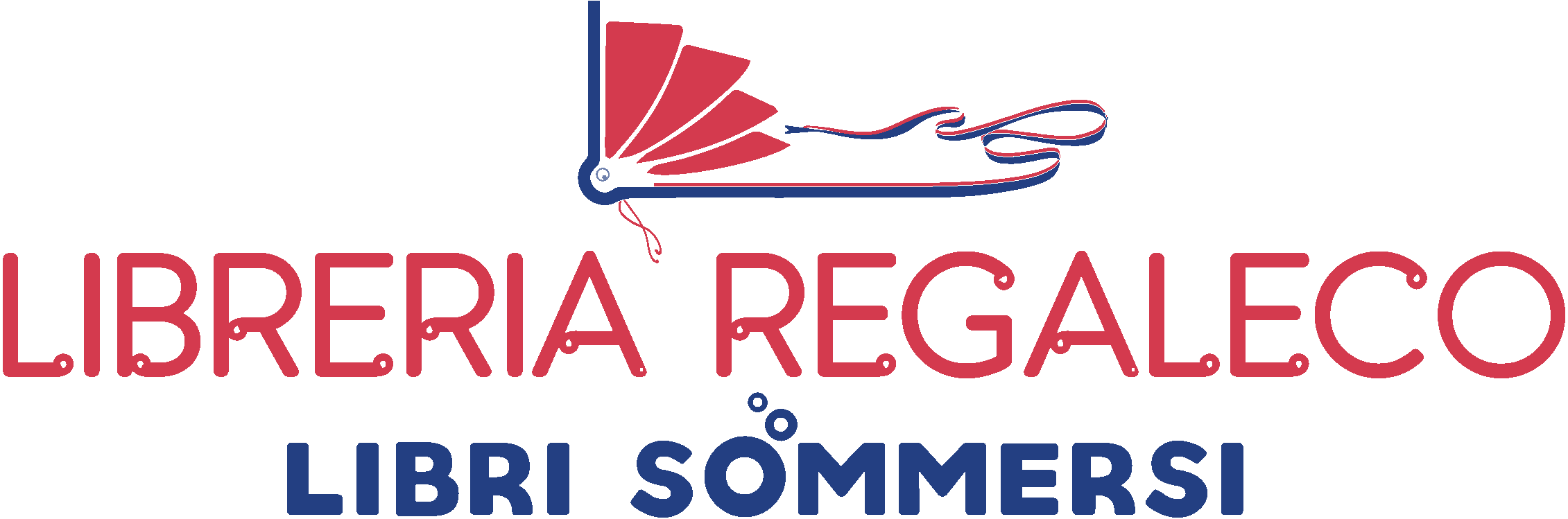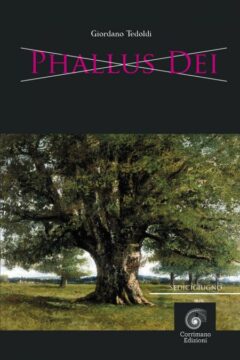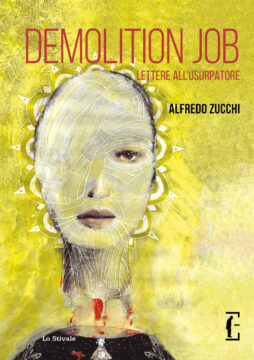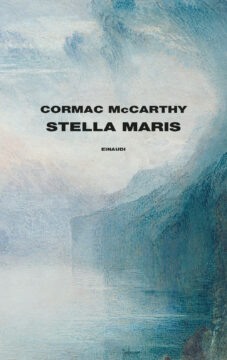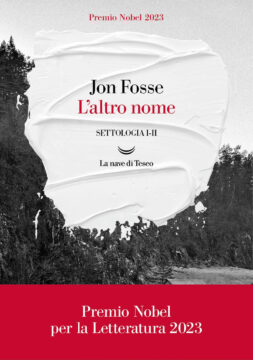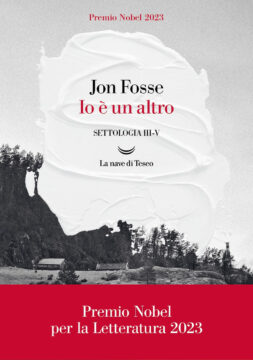- You have no items in your shopping cart
- Continue Shopping
Phallus Dei, di Giordano Tedoldi (Corrimano Edizioni, 2024)
Se volessimo trovare un autore in Italia che più di ogni altro, con il suo percorso, può essere esemplificativo dell’andamento della nostra industria editoriale, quell’autore sarebbe Giordano Tedoldi. Nato a Roma nel 1971, esordisce con la raccolta di racconti Io odio John Updike (Fazi, 2006, poi riproposta da Minimum Fax nel 2016), e prosegue pubblicando i romanzi I segnalati (Fazi, 2013), Tabù (Tunué, 2017) e Necropolis (Chiarelettere, 2019). Fino a qui tutto bene e tutto “nella norma”, verrebbe da dire, perché parliamo di uno degli scrittori più interessanti del panorama della letteratura italiana contemporanea che pubblica romanzi e racconti in collane di narrativa letteraria ma allo stesso tempo “di confine”, che lasceranno un segno nell’editoria indipendente degli ultimi vent’anni. Tedoldi però, già nel 2012, decide di intraprendere anche la strada dell’autopubblicazione, e lo fa con il romanzo Deep Lipsia – la storia di un gruppo di neonazisti con uno dei finali più belli e stranianti della nostra letteratura recente – scritto (parole dell’autore), “seguendo un unico dogma: i personaggi non devono pensare”. Deep Lipsia verrà poi inserito anche nella seconda opera autopubblicata da Tedoldi, Decomposizione della letteratura, una raccolta di testi narrativi di diversa lunghezza che l’autore decide di far uscire autonomamente nel 2021, già due anni dopo l’ultima sua precedente pubblicazione con Chiarelettere.
E così arriviamo al 2023, l’anno di Phallus Dei. È un percorso, quello di Tedoldi, che, come già accennato, fotografa bene la storia recente dell’editoria indipendente italiana. Dal 2006 infatti molte cose sono cambiate: la collana Romanzi di Tunué e Altrove di Chiarelettere hanno chiuso i battenti, e minimum fax non è più la casa editrice di riferimento per chi cerca una narrativa nuova e in qualche modo di rottura.
Tornando però a Phallus Dei, anche nel caso della prima edizione di questo romanzo bisogna parlare di autopubblicazione. Giordano Tedoldi dichiara di non avere, almeno in un primo momento, trovato editori interessati a questa opera e ha quindi inizialmente pubblicato in autonomia il testo su Amazon, in versione digitale. È quantomeno curioso, ma forse sarebbe più giusto dire deprimente, che un romanzo letterario, diverso da tutto quello che si pubblica oggi, con un’attenzione particolare alla lingua e alla struttura, faccia fatica a trovare spazio in un settore in cui la letterarietà, la diversità e il lavoro su prosa e costruzione dovrebbero rappresentare un valore.
Phallus Dei racconta la storia di Sodal Sodal, vice-addetto alla pulizia dei bagni dell’azienda Axum, che un giorno viene invitato dall’amministratore delegato della società, Durkheim, a pranzare in un ristorante di lusso. Durante il pranzo, Durkheim mostra una fotografia compromettente che il diretto superiore di Sodal avrebbe inviato a una collega, una fotografia del suo sesso. Da questo momento in poi Durkheim si dimostrerà ossessionato dalle dimensioni dei genitali altrui e offrirà a Sodal la possibilità di scalare velocemente le gerarchie della Axum proprio in virtù delle dimensioni ragguardevoli del suo membro. Una premessa narrativa di questo tipo permette a Tedoldi di costruire un universo letterario in cui ogni svolta è contemplata e possibile, e in cui fortunatamente niente ha bisogno di essere davvero spiegato, neanche il fatto che la moglie del protagonista, Miranda, sia in grado di piegare i cucchiai con la forza del pensiero.
Quello che maggiormente sorprende di Phallus Dei è la sua capacità di vivere di contrasti e di muoversi in una sorta di zona di confine. Resta sospeso tra i generi senza mai diventare un testo di genere, è allo stesso tempo divertente e amarissimo, pieno di trovate e di personaggi memorabili, è disturbante fino al disgusto eppure difficile da mollare e viene portato avanti con un rigore formale anche nel suo diventare a poco a poco un testo eterogeneo per stile e contenuti. Il modo in cui Tedoldi usa la lingua e costruisce l’architettura di Phallus Dei è ovviamente, evidentemente, quello di uno scrittore con una visione, un immaginario e un approccio al testo unici, e questo approccio fa del romanzo un’opera simile a pochissime altre e, anche per questo motivo, preziosa.
Dispiace che Phallus Dei abbia fatto fatica a trovare spazio, e dispiace tanto per i lettori quanto, e forse ancora di più, per gli editori (grandi, medi e piccoli) che stavano per lasciarsi scappare uno dei romanzi migliori dell’anno. Stavano, appunto, perché oggi Phallus Dei un editore l’ha finalmente trovato: sarà Corrimano Edizioni a portare l’ultimo romanzo di Giordano Tedoldi in libreria. È importante che un testo così arrivi ai lettori e che se ne parli, perché marca la distanza tra quello che in Italia oggi viene proposto e arriva sugli scaffali e chi invece prova, in questo caso riuscendoci, a fare letteratura. Distanza che sembra aumentare sempre di più e che invece grazie a testi come questo sarebbe possibile, almeno ogni tanto, chiudere. La speranza è che la funzione di Phallus Dei non sia soltanto quella di arricchire un catalogo con un nome di prestigio, e che l’editore che si è preso carico di questa opera importante faccia quello che è nelle sue possibilità per dare il giusto peso a un’uscita che meriterebbe di far parlare di sé più di quanto fino a oggi sia riuscita a fare.